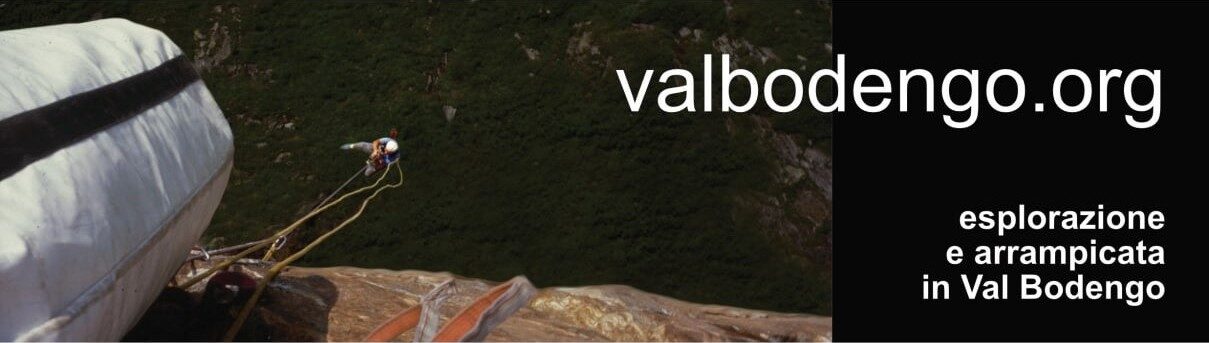E’ passato quasi un anno da quando precipitosamente, ancora fradici per un violento temporale, avevamo abbandonato la parete, lasciandoci alle spalle un lungo serpente di corde fisse, con il chiaro intento di ritornaci, di lì a poco. Ma così non sarà. Subito dopo eravamo partiti per Yosemite, avevamo salito il Fairview Dome, la Washington Column, El Captain lungo la Triple Direct (1.300 m di 5.9 e A2). Al rientro in Italia, il gruppo era fisicamente e psicologicamente a pezzi e così nessuno pensò a portare a termine l’itinerario in ValB.
Così un anno dopo siamo solo in due e avanziamo quasi strisciando sotto il peso di zaini ancora più massacranti per la mancata suddivisione del materiale di arrampicata in più compagni di avventura. Non ci vuole più di un’ora e mezzo per giungere all’attacco della parete, ma rischiamo oltre modo per avvicinarsi alla base della ‘Ragnatela’, ultimo punto per un sicuro rifornimento di acqua per la parete. Per non salire e poi scendere, cosa che alla fine finiremo comunque col fare, tentiamo un traverso a mezza costa con il risultato di trovarci in mezzo a risalti rocciosi che mettono a dura prova le nostre capacità, lontani l’uno dall’altro. Alla fine comunque la preziosa acqua è nelle bottiglie e nella tanica.
Dalla sella all’attacco della parete, risalendo uno scosceso pascolo, poi la scena si tinge di patetico: ogni venti passi siamo costretti a passarci la tanica di plastica morbida contenente una ventina di litri d’acqua mentre, procedendo, continuiamo a inciampare cadendo rovinosamente a terra sotto il peso dello zaino. In una di queste cadute Paolo perde la presa sulla tanica che inizia a rotolare verso valle. Con l’immane peso sulle spalle, Paolo tenta una goffa rincorsa mentre la tanica acquista sempre più velocità; in un lampo, si rende conto che la distanza tra lui e la tanica sta aumentando e così gioca la carta della disperazione: si lancia in tuffo, faccia a valle, con le braccia protese e agguanta la tanica. Quello che segue è il rotolamento di un ammasso informe di Paolo, zaino e tanica, in una qualche forma di amplesso che termina con Paolo esausto, sdraiato sulla schiena, seriamente addolorato alla spalla.
Questo ripido pascolo, che nel complesso dà l’idea di un morbido prato, in realtà ricopre assai superficialmente il ghiaione costituito di grossi blocchi di pietra caduti dalla parete e che spuntano qua e là rendendo incerto il cammino e dolorose le cadute.
Qui ogni anno arrivavano i pastori di Corte III a sfalciare l’erba per l’inverno e curare il pascolo, mantenendolo pulito da arbusti e larici.
Non siamo ancora giunti alla base della parete che inizia a piovere, ci affrettiamo, si scivola. La parete strapiombante ci offre un primo riparo, ma il vento spinge la pioggia e la grandine verso la sua base, dove ci siamo accasciati, esausti. Scende la notte e non abbiamo portato le frontali. Al buio costruiamo un piccolo rifugio addossato alla parete: i due muri laterali sono formati da un muretto a secco da una parte e da una grossa lastra di pietra che faticosamente riusciamo a ruotare nella posizione voluta dall’altra, per tetto abbiamo steso il telo termico, l’entrata è protetta da un espanso mentre l’altro è sotto il culo per ammorbidire la superficie. Siamo all’asciutto ma lo spazio è poco. Così è con gran sollievo che, riaprendo gli occhi nel cuore della notte ora illuminata da una splendida luna piena, posso uscire dal rifugio e stendermi fuori, nel sacco a pelo.
Arriva l’alba. Non abbiamo il fornelletto così un po’ di sciroppo aromatizzato serve per insaporire l’acqua e darle la parvenza di un the freddo, qualche biscotto e siamo pronti.
Le corde sono ancora lì che pendono dalla parete con aria bonaria, quasi a convincerci di non avere timore. Ma in realtà la paura c’è: la prima fissa non è bagnata, ma il colore è mutato dal viola carico a un violetto assai pallido e il suo calibro sembra raddoppiato. Proviamo ad appenderci in due, con tutto il peso, ci dondoliamo: si allunga, ma tiene. Allora monto le due maniglie jumar e parto, perplesso, cercando di caricare la corda in modo graduale, senza scatti; salendo piazzo qualche friend, ai quali mi assicuro con un’altra corda, quella che useremo per l’ascensione, quella già usata per l’ascensione a El Cap (meno due metri irrimediabilmente lesionati). Più salgo e più mi rendo conto che le protezioni che riesco a piazzare appaiono ridicole in confronto all’enorme distanza che passa tra l’una e l’altra, e il nodo in cima fatto quasi un anno fa? Del resto la via di salita, quella con chiodi e spit è troppo a destra e non si può raggiungere. Allora che fare? Salire cercando di non pensarci troppo! Cinquanta metri prima su di un muro verticale e poi nel vuoto non finiscono più e poi ho perso la mano a risalire, sono affaticato, ci metto un’eternità. Arrivo in sosta (S3 della via), è tutto a posto e recupero il saccone bianco con le fettucce nere, aiutato da Paolo che lo segue.
La seconda corda è arancione, regalataci dalla SEM perché ormai a fine carriera, affaticata dal peso di mille corsi di alpinismo e di roccia, e oltretutto è di diametro inferiore e completamente bagnata; è la corda con cui dobbiamo superare l’impressionante serie di tetti, ma fortunatamente Paolo risale lungo la via assicurandosi agli spit con l’altra corda anche se lo sforzo è tremendo per mantenersi attaccato alla roccia strapiombante. Paolo è in sosta (S6). Ora è il mio turno di risalita, ma quando stacco il saccone dall’ancoraggio lo vedo schizzare fuori dalla parete di una decina di metri e allora capisco che farò la stessa fine. Mollare l’ultimo ancoraggio prima di partire mi richiede un supremo sforzo (di volontà), controllo le maniglie per l’ennesima volta, sono attaccato alla corda per quegli stupidissimi dentini della maniglia; ora sono nel vuoto che ondeggio spaventosamente con la sensazione, come nel pendolo di Foucault, che non mi fermerò mai; mi giro su me stesso, vedo lo spaventoso vuoto sotto di me, mi paralizzo, chiudo gli occhi, cerco di calmarmi, ma non mi fermo. Come posso calmarmi mentre sono appeso su una corda forse marcia, su due maniglie e volteggio nel vuoto? Poi realizzo che l’unico modo per porre fine a questo supplizio è di risalire. Faticosamente così raggiungo la sosta, dove avevamo fatto il primo bivacco l’anno prima.
Ora manca l’ultima corda fissa, la più lunga, 50 metri esatti, la più sottile, una corda da 9 mm. La risalita comunque segue per quasi 25 metri la via di salita e quindi posso assicurarmi agli spit saldamente infissi nella roccia. Quando il saccone e poi Paolo mi raggiungono alla sosta (S8): siamo tornati al punto più alto raggiunto la scorsa estate quando quel catastrofico temporale mattutino (n° 1) bagnò le nostre polveri, costringendoci ad abbandonare frettolosamente e forse prematuramente la parete.
E’ Paolo ad avventurarsi oltre, a disegnare la salita, sempre impegnativa ma ora solo verticale, non più strapiombante. Arriva così un piccolo anfratto, che battezziamo “antro” non certo per la sua dimensione ma perché unica minima rientranza nella parete monolitica, incastonato di preziosi cristalli di quarzo e dove un falco aveva fatto il suo nido una qualche primavera. Non è un punto di sosta particolarmente comodo, ma è estremamente logico (S9).
E’ tardo pomeriggio e supero il corto strapiombo (7-8 m) sovrastante l’antro; si ode ora il rumore di tuoni, sempre più vicini. In un attimo dall’alto, sopra la parete, spinte da Nord, appaiono le prime nubi nere cariche di pioggia. A una piccola cengia pianto uno spit e mi calo velocemente nella grotta dei cristalli e del falco, dove Paolo ha già pensato come sistemare il bivacco. Lo spazio è molto ridotto e non c’è spazio per distendere completamente l’amaca, che forma così un angolo quasi retto. Per proteggerci stendiamo il telo termico sopra le nostre teste, ancorandolo ai quattro angoli a chiodi e friend con il sistema del cordino e del sassolino: si tratta di avvolgere una scheggia di roccia con l’angolo del telo e strozzare questo rigonfiamento con un cordino che poi si assicura al chiodo in parete. Semplice, geniale e soprattutto funzionale. Siamo al coperto ora, mangiamo qualcosa, roba fredda. Siamo stravolti. Da principio aveva iniziato a piovere piano ma ora sta aumentando d’intensità, si alza il vento, raffiche di aria fredda portano gocce impazzite, scoppia il temporale (il n° 2 in parete). Buchiamo gli espansi e li leghiamo con cordini al tetto per formare una sorta di “parete” che chiuda l’antro. Siamo ora di nuovo all’asciutto. Riprendiamo a mangiare, seduti sull’amaca, con le gambe a penzoloni nel vuoto che si apre sotto di noi; beviamo acqua aromatizzata con sciroppo di menta.
E’ buio, la luna sorgerà solo tra 2-3 ore, è, infatti, leggermente calante. Nel nostro rifugio è ancora più buio e sentiamo la mancanza di una frontale che “riscalderebbe” un poco l’antro, allieverebbe il senso di malinconia che ti attanaglia quando scende la notte. Non siamo due allegroni ma con Paolo riusciamo a farci compagnia, infatti, non mi sento solo, o forse ci sentiamo soli in due in quell’angolo minuscolo della valle. Sappiamo che sarà una notte interminabile, fatta di lunghe attese e di brevi riposi. Continua a piovere e inizia a fare un po’ di freddo; decidiamo di tirare fuori i saccopiuma. Cristo, sono bagnati! La tanica con l’acqua di riserva si è rotta nel saccone da recupero. Tiriamo fuori tutto ciò che resta, appendendolo alle corde fisse che attraversano l’antro e tutte convergono a un pilastrino che sorge isolato nel suo centro, al quale Paolo si era aggrappato terminando la sua faticosa lunghezza (L9). Sul fondo nuotano gli scarponcini e con la testa e le spalle inghiottite nel saccone riesco ad afferrarli: così fradici pesano un quintale l’uno; li strizziamo per quanto riusciamo; poi è il saccone stesso a finire a testa in giù, per svuotarlo dell’acqua. Ci guardiamo perduti, che facciamo? Entriamo nei saccopiuma che sono fradici o quantomeno umidi nelle loro parti migliori? Il freddo decide per noi: dobbiamo farlo e ci sdraiamo, Paolo sopra ed io sotto. Mi convinco sempre più che non esistono posti comodi per piantare un’amaca. Ancora una volta siamo disperatamente scomodi: Paolo è sdraiato malamente con le gambe che formano un angolo retto con il busto, la mia amaca è leggermente più distesa, ma il suo culo preme sulle mie cosce chiedendo alle mie ginocchia una innaturale iperdistensione; quando poi si muove, mi assesta delle micidiali gomitate in faccia. Non so se sia aumentata la pioggia o se la grande parete impregnata d’acqua abbia formato cascate d’acqua, fatto sta che a metà notte sul nostro tetto iniziano a cadere acqua rivoli d’acqua e si formano pesanti sacche che Paolo svuota continuamente tenendo le braccia alzate. Poi sente i piedi bagnati; l’acqua sta scivolando lungo la parete dell’antro e accarezza i saccopiuma; ho i piedi fradici anch’io e sento che l’acqua lentamente progredisce, le caviglie, i polpacci, le cosce e infine ristagna sotto il culo; ora il corpo risale e l’acqua si ferma, almeno il busto rimane asciutto. La posizione è assurda, sento una fitta lancinante alla schiena, riesco faticosamente a girarmi un poco sul fianco sinistro, di più non mi è concesso, anche se lo vorrei con tutte le mie forze, quando una mano gelida si appoggia sulla mia spalla destra. Cristo! Un rivolo d’acqua, scivolando all’interno dell’espanso, mi aveva inzuppato anche questa parte del saccopiuma. Ritiro affannosamente il lembo fradicio sottraendolo in parte allo stillicidio e mi abbandono nell’amaca. Sono disperato, non so più cosa fare, ho i piedi congelati, laggiù il saccopiuma si è ridotto in palle di piume fradice e due sottili teli di naylon, l’acqua penetra dappertutto, non lotto più. Ancora una volta mi rinchiudo in una resistenza passiva aspettando che qualcosa accada; ho imparato che con lo sfinimento arriva anche il sonno, dei brevi attimi di ristoro, tempo che passa verso la probabile fine della sofferenza. Paolo là sopra è distrutto, completamente bagnato, ha le braccia a pezzi nel tentativo di allontanare le sacche d’acqua dal tetto; poi si ricorda di una foto di Royal Robbins sdraiato di traverso sull’amaca e così risolve uno dei problemi sottraendo i piedi alla cascata. Poche parole ma ci facciamo compagnia, non parliamo di ora ma di domani, quando si ripartirà, quando si stenderà tutto al sole ad asciugare; Paolo ha un atteggiamento positivo, reagisce con rabbia alla sfiga, non si annichilisce certo e questo è di grande aiuto.
Le prime luci dell’alba accendono la spasmodica attesa del primo raggio di sole. Le tinte rosse dell’aurora appaiono dietro le lontane montagne dell’Albigna, repentinamente s’illumina la punta del Cavregasco, di fronte a noi; basta questa luce riflessa per darci la forza di uscire dai saccopiuma e consumare una modesta colazione, biscotti secchi e acqua fredda aromatizzata con sciroppo al the. Il sole tarda ad arrivare perché se la parete è esposta a Sud, l’antro che ci ha dato riparo è orientato a Sud-Ovest; così riparto prima di essere colpito dai raggi calorifici. Risalgo le corde fradice e arrivo alla cengetta dove ieri avevo abbandonato.
Supero questa balza di roccia e repentinamente la parete cambia inclinazione e mi appare il pilastro staccato!
Un diedro aperto, che dopo duecento metri di strapiombi continui mi appare oltremodo appoggiato, mi porta rapidamente all’attacco del camino che divide il pilastro dalla parete, che ora forma un ampio anfiteatro tutt’intorno. La cima è ancora lontana ma s’intravedono alberi sulla mia destra e più su, in alto. Non vedo l’ora che Paolo risalga per commentare insieme questo incredibile cambio di scenario. Eccolo apparire dal baratro, si guarda in giro, sorride, anche lui è felice; siamo in pieno sole adesso; la voglia di salire ancora ci assale. Paolo s’infila dentro il camino ancora bagnato, guadagna metro su metro, si diverte, arriva all’ampia sella che divide il punto dove il pilastro si stacca definitivamente dalla parete e va verso la sua cima indipendente. E’ la prima sosta (S11) in cui ci si possa sedere tranquillamente e slegarsi. Paolo è li che mi aspetta, raggiante, ha percorso una delle lunghezze più belle che ricordasse. Una frattura orizzontale attraversa l’intero pilastro, guardiamo meglio per scoprire che la parte alta è un enorme blocco appoggiato. E’ poco più di una piccola guglia, ma quel pilastro tanto atteso e sognato mi appare ora come una delle forme più emozionanti mai viste.
Davanti a me l’unica fessura della parete; una ventina di metri che percorro in dulfer o con incastri di piede e mani, con l’unico friend del 4, spostato di metro in metro. La festa, però, dura poco. Non senza difficoltà arrivo ad un tratto più appoggiato, costellato di piccole cenge scoscese ed erbose, dove faccio la sosta (S12): davanti a me un altro salto di placche lisce e verticali. Un breve conciliabolo su come affrontare questo nuovo e inaspettato ostacolo, poi Paolo decide di affrontarlo sui ganci! Dopo una quindicina di metri, si odono i primi sordi tuoni; è solo metà pomeriggio, ma il temporale (il n° 4 in parete) è già in arrivo. Pianta uno spit e si prepara a scendere mentre rinforzo la sosta perché ormai il bivacco è sicuro.
Stavolta siamo in piena parete aperta, senza il benché minimo riparo. Tiro una corda fissa sopra le amache e stendo il telo termico a capanna, legato come sempre, con sassolino e cordino. Paolo, geniale in queste occasioni, apporta una modifica determinante: mette i due espansi contro la parete per isolarci dall’acqua che già inizia a scivolare lungo la parete; tutto il telo termico è così destinato a coprirci dall’acqua che arriva dall’alto. Il temporale si scatena, violento come lo aspettavamo, l’acqua picchia violentemente contro la nostra esile copertura. Ma stanotte è diverso, sappiamo che sarà l’ultima notte, siamo vicini alla cima; che siamo in alto lo capiamo anche perché l’acqua che cade non fa in tempo a organizzarsi in rivoli e poi diventare torrente e cascata, come era successo là sotto, più in basso. E questa notte il nostro riparo, apparentemente così fragile e perduto nella grande parete, reggerà, non una goccia d’acqua ci sfiorerà. Paolo, come le altre notti, dorme sopra, barattando un po’ di sicurezza (le pietre dall’alto) per una briciola di comodità.
L’alba arriva gioiosa come non mai; eccitati, nel nuovo giorno, smontiamo il bivacco e Paolo risale agilmente la corda lasciata il giorno prima, inondato dalla luce del sole. Ancora un’impegnativa fascia di roccia verticale lo divide dalla linea dell’orizzonte tra pietra e cielo. Accarezza, aggirandolo, un enorme blocco appoggiato nell’ultimo tratto del diedro terminale verticale, ed esce su una comoda cengia (S13). Arrivando alla sosta, ho immaginato lo stupore che deve averlo colto nell’attimo in cui il suo sguardo, sempre proiettato verso l’alto in questi giorni, ha potuto abbassarsi e guardare avanti a sé il morbido succedersi di brevi placchette rocciose, cenge erbose e radi alberi. Mi arrampico facilmente per altri 50 m, seguendo ora tracce d’acqua, ora balze erbose, per uscire definitivamente sui pascoli sommitali (S14).
E’ la tarda mattina di un radioso giorno di sole, quando a poco meno di un anno da El Cap, ancora una volta rovesciamo il saccone, sul prato, in mezzo a macchie di rododendro, e disponiamo tutta la nostra roba ad asciugare sulle calde lastre di granito. Ci scoliamo le residue riserve d’acqua e indugiamo per rendere più lungo questo momento di gioia e soddisfazione.
La discesa è ancora tutta da inventare. Decidiamo di tornare direttamente alla base della parete, dove ci attendono i due zaini, invece che tentare di raggiungere, se mai possibile, la traccia che dalla forcella di Strem scende fino a Corte Terza. Superiamo il filo di cresta per affacciarci sulla parete Occidentale di Strem, piantiamo i primi due spit di calata e atterriamo su cenge che degradano su un salto impressionante. Risaliamo allora una ventina di metri, portandoci ancora più a Occidente, in un canalone parallelo. Una doppia e procedo al recupero delle corde tirando la corda yosemitica, ma l’altra corda, quella viola, sale una decina di metri e poi si blocca. Iniziamo bene! Dove cazzo si è incastrato quel nodo? Il pendio è molto ripido e l’orrendo baratro si apre appena sotto, ho paura ad appendermi e tirare con tutte le forze: il nodo potrebbe disincastrarsi all’improvviso e proiettarmi all’indietro, sbilanciato, verso l’abisso. Ma in breve mi accorgo che neanche appendendomi con tutto il peso riesco a smuovere quel dannato nodo, si unisce Paolo, ci appendiamo in due, ci spostiamo in diverse direzioni per tirare il nodo da diverse angolazioni, siamo esausti. Paolo allora decide di risalire le corde, così arrampica per una decina di metri per recuperare il capo dell’altra corda e quando lo afferra si accorge che questo lo segue docilmente; tempo di realizzare ciò che era successo e quindi una serie infinita di insulti in mia direzione: mi ero semplicemente accanito a recuperare la corda sbagliata!
Altri due spit e finalmente la seconda doppia è predisposta e scendiamo in un ampio valloncello coperto di pietre e pascoli che degradano verso un altro salto, sul cui ciglio troneggiano alcuni magnifici abeti. Camminiamo fino al bordo del salto e cingiamo un grosso abete con un cordino e giù per altri 50 m. Ci fermiamo su di una cengetta dove la roccia ci sfugge sotto i piedi, non si vede il fondo. Altri due spit e incrociamo le dita; inizio la discesa con molta calma, supero questo ennesimo bordo e mi ritrovo nel vuoto: una parete monolitica di splendido granito grigio rientra in modo spaventoso e in breve mi ritrovo ad una decina di metri dalla roccia, guardo verso il basso e, con sollievo, vedo i due capi delle corde che sfiorano la base della parete, dopo 50 m esatti di vuoto impressionanti. A volte mi chiedo se non vi siano delle misure naturali, delle distanze che un Demiurgo ha prefissato tra una cengia e un’altra, a cui noi ci siamo adeguati con la lunghezza delle nostre corde, perché se no non mi spiegherei di coincidenze come questa. Tocco terra, sono felice, siamo tornati alla base di Strem! Facili passaggi su roccia ci riportano in breve al pascolo alla base della parete, ai nostri zaini.
Ancora un paio d’ore di discese su doppie in un canalone ci riportano all’abitato di Corte Terza, mentre cadono le prime gocce di pioggia; ci giriamo, la parete è un’altra volta immersa in nubi nere e temporalesche, ma ora siamo a terra. Alle baite c’è gente, ci hanno visto salire faticosamente lungo la parete verticale; un pastore ci confessa di avere perso due giorni di lavoro per seguire il nostro lento progredire, solo stamattina, quando siamo usciti in cima, ha abbandonato il suo punto di osservazione per andare verso Valle.
E’ fatta, siamo felici.